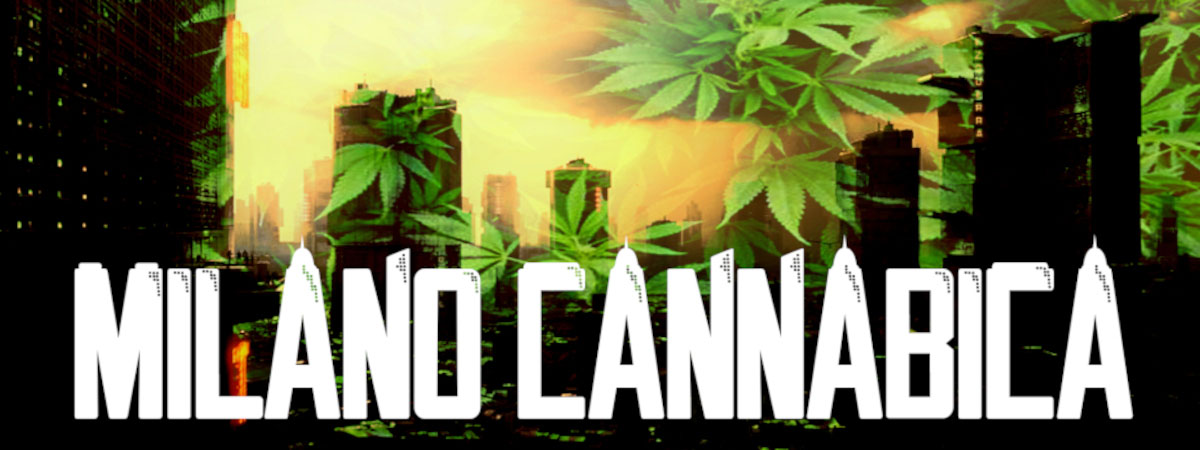28 Agosto 2025
https://www.fuoriluogo.it/mappamondo/il-compromesso-uruguayano/
Il nuovo studio di Rychert, Pardal e Queirolo fa i conti del “modello Uruguay”.
Dieci anni dopo la legalizzazione, l’Uruguay continua a essere un laboratorio fra i più osservati del mondo sulla regolazione della cannabis. Ma quanto vale davvero quel mercato “a guida pubblica” e chi ci guadagna? A queste domande risponde lo studio di Marta Rychert, Mafalda Pardal e Rosario Queirolo, appena uscito sul Journal of Illicit Economies and Development. Gli autori mappano attori, scelte imprenditoriali e flussi di ricavi dentro un sistema disegnato – dalla legge del 2013 – esplicitamente per perseguire obiettivi di miglioramento della salute, della sicurezza e della tutela dei diritti umani e non per massimizzare le entrate statali o i profitti privati.
Il modello uruguayano prevede tre vie legali e esclusive di accesso per i consumatori al di fuori del canale medico: autocoltivazione domestica (fino a 6 piante), Cannabis Social Club (15–45 soci, fino a 99 piante in fioritura) e acquisto in farmacia; i consumatori devono registrarsi e possono attingere a un solo canale alla volta, con tetto di 40 grammi al mese/480 l’anno. Prezzi, volumi e (per la farmacia) tipologie/profilo di potenza sono controllati dal governo. È un framework “state-controlled”: niente accise e niente advertising. Anche niente cannabis tourism, in quanto solo i residenti possono registrarsi ed acquistare, anche se ovviamente si è creato un certo mercato grigio.
Alla data dell’analisi (gennaio 2024) vi erano 13.118 autocoltivatori registrati; 355 CSC con 12.119 membri (media 34 per club); 38 farmacie abilitate e 66.270 utenti registrati su questo canale (diventati rispettivamente 42 e 78.955). L’acquisto in farmacia, seppur partito per ultimo (luglio 2017), è il canale più usato.
La coltivazione per la rete delle farmacie è affidata a poche imprese for-profit selezionate da IRCCA, con produzioni localizzate e test di qualità stringenti. In un mercato dove prezzo, varietà e potenze sono decisi dall’Autorità, lo spazio imprenditoriale si riduce all’efficienza dei costi: un modello “commoditizzato”, con economie di scala e minima differenziazione (persino il packaging è normato e la comunicazione commerciale vietata). Nel 2022 è arrivata in farmacia la varietà Gamma (~15% THC), nel 2024 Épsilon (fino al 20% THC), a fianco delle storiche Alfa/Beta; il prezzo medio al dettaglio (marzo 2024) è intorno a 2,4 $/g (11,8 $ per la confezione da 5 g), più del doppio rispetto al 2017.
Vendere cannabis in farmacia richiede adeguamenti minimi (l’hardware fornito da IRCCA), ma resta il vincolo cash only per via dei rischi legati al fatto che il sistema bancario uruguagio è strettamente legato a quello USA, e quindi vincolato alle norme che impediscono alle banche statunitensi di raccogliere denaro da aziende che – pur lecitamente nello Stato – partecipano ad un mercato vietato dalla legge federale sulle droghe. Un freno, secondo lo studio, soprattutto per le grandi catene. Nella pratica, le farmacie possono differenziarsi solo su orari e organizzazione del servizio (alcune gestiscono liste di avviso ai clienti abituali).
I Cannabis Social Club (CSC) sono associazioni senza scopo di lucro, ma nella realtà mescolano missione sociale e gestione economica (affitti, energia, personale). Possono fissare prezzi e potenze liberamente, e questo li rende più flessibili della farmacia ma, mediamente, più cari per l’utente. Modelli di governance diversi coesistono: dai club cooperativi dove i soci contribuiscono al lavoro, fino ai “quasi-dispensari” dove prevale un’impostazione manageriale e pochi ruoli chiave sono retribuiti.
Partendo dai dati IRCCA sulle vendite in farmacia (~3,26 tonnellate nel 2023) e dai prezzi medi, gli autori stimano un giro d’affari retail in farmacia di ~7,4 milioni di dollari. Di questi, il 55–65% finisce ai produttori (4–4,8 milioni), mentre le farmacie trattengono ~15–30% (1,1–2,2 milioni). Per i CSC, l’assenza di un listino uniforme impone due scenari: ~8 milioni usando prezzi medi storici, fino a ~17,7 milioni indicizzando ai rincari osservati nel canale farmacia. Mancano dati per stimare i profitti netti (i costi operativi di questi soggetti non sono pubblici).
Il disegno uruguayano ha evitato la concentrazione delle corporation e contempla (almeno in linea di principio) l’inclusione di persone con precedenti per reati legati alla cannabis, senza barriere formali all’ingresso nel legale (come lavoratori, soci di CSC o, con capitale adeguato, produttori). Ma le barriere economiche per la produzione autorizzata restano alte e l’assenza di negozi o dispensari al dettaglio concentra i benefici retail nei titolari di farmacia. Nei CSC l’accesso è più facile, ma i dividendi non esistono per definizione: a trarne reddito sono al massimo pochi addetti, mentre ai soci resta un mix di appartenenza, qualità e adeguamento dei profili della potenza del prodotto alle proprie preferenze, e (non sempre) risparmio. In sintesi: un compromesso tra tutela pubblica e spazi economici, con margini di miglioramento sul fronte dell’equità.
Mentre in Europa si discute di modelli “di mezzo”, il caso Uruguay mostra che regolare non significa commercializzare senza freni: si possono guidare prezzi, prodotti e volumi senza azzerare l’iniziativa privata e contenendo il profitto. Ma la giustizia economica non discende automaticamente dalla regolazione: va progettata (licenze, canali retail inclusivi, finanza) se si vuole allargare davvero la partecipazione ai frutti della legalità.