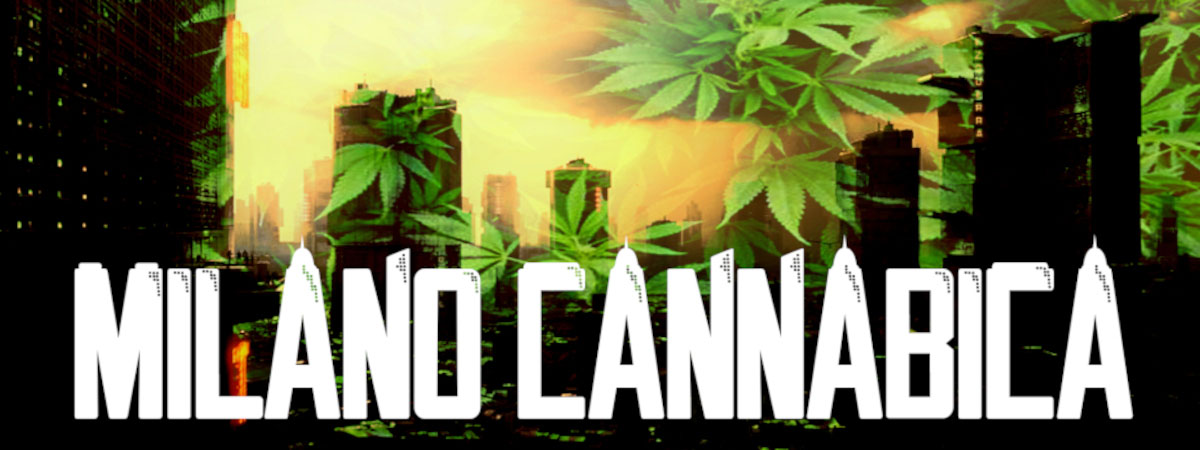25 Giugno 2025
www.elsevier.com/locate/drugpo
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955395925001616
Mary Jean Walker
Questo articolo indaga l’utilizzo di un approccio di proporzionalità per esaminare il ragionamento etico che potrebbe giustificare le politiche sull’uso ricreativo di droghe.
Il principio di proporzionalità afferma che, per essere eticamente ammissibile, una politica dovrebbe verosimilmente imporre solo danni o rischi proporzionati ai suoi benefici.
Il principio si riscontra in vari contesti in cui danni o rischi vengono imposti alle persone, come la punizione penale o la guerra. Il mio obiettivo è dimostrare che un approccio di proporzionalità può fornire un modo per arricchire la nostra comprensione del ragionamento morale e delle affermazioni normative che possono influenzare il pensiero politico.
Negli ultimi anni si è assistito a un crescente numero di ricerche volte a comprendere il ruolo delle visioni morali, o valori, nel definire e orientare le politiche sulle droghe.
Gli studi hanno esaminato quali valori siano alla base delle politiche sulla droga attraverso l’analisi del dibattito pubblico (Ritter, 2020; Lerkkanen & Storbjörk, 2023) e parlamentare (Curchin, Weight & Ritter, 2022, 2025), interviste con le parti interessate (Zampini, 2018) o persone con esperienza vissuta (Askew & Ritter, 2023); e indagini incentrate sulla teoria basate su una gamma di prospettive politiche ed etiche, soprattutto, ma non esclusivamente, sulla riduzione del danno (ad esempio, Stevens, 2011; Dea, 2020; Hoffman, 2020; Porter, 2020; Nicholls, 2024; Ritter & Barrett, 2024).
Questo si basa su precedenti lavori volti a identificare il ragionamento etico e le rivendicazioni implicite nelle politiche antidroga (ad esempio, Ezard, 2001; Wodak, 2007; Kleinig, 2008), nonché su argomentazioni normative su quali politiche antidroga dovrebbero essere adottate (ad esempio, Husak, 1992).
Il recente rinnovato interesse per l’etica e le politiche antidroga ha messo in discussione l’idea che le politiche antidroga possano o debbano basarsi esclusivamente sulle prove, riconoscendo che le prove stesse sono socialmente posizionate e cariche di valori (Lancaster, 2014; Ritter, 2020) e che la distinzione tra politiche basate sulle prove e politiche basate sui valori è artificiale (Zampini, 2018; Lerkkanen & Storbjörk, 2023).
Questo è stato sostenuto da prospettive di teoria critica e studi scientifici e tecnologici, e sarebbe anche in linea con le epistemologie sociali e femministe (Anderson, 2024) e con le argomentazioni della filosofia della scienza (Douglas, 2000).
Aggiungerei che, dato che la politica è un impegno pratico e implica azione, non possiamo aspettarci che sia priva di valori perché ha obiettivi, ovvero l’intenzione di intervenire e modificare il mondo. Le prove sono di vitale importanza per aiutarci a comprendere lo stato del mondo (informazioni quantitative e qualitative sul contesto politico) e i meccanismi causali che si prevede intervengano tra gli interventi e i loro effetti (dati causali correlazionali e meccanicistici).
Ma i fatti non possono dirci cosa dovremmo mirare a fare. Come ci ha insegnato Hume, il “dover essere” non può mai essere derivato dall’”essere”: un’affermazione normativa, o un’affermazione su ciò che dovremmo fare, non può logicamente derivare da alcun insieme di affermazioni puramente descrittive (Hume, 1969, 507-521 (III.1.1); si veda anche Moore, 2005).
Nei casi in cui le affermazioni sul “dover essere” sembrano derivare da affermazioni sull’”essere”, vi è necessariamente una premessa normativa implicita e repressa. Se la politica deve coinvolgere alcuni o altri valori, è meglio renderli espliciti in modo da poterli mettere in discussione, ragionare e discutere.
Questo articolo si propone di approfondire i lavori recenti sviluppando e applicando un’analisi del principio di proporzionalità.
Valutare le politiche antidroga in termini di proporzionalità consente di riconoscere le diverse forme di ragionamento etico che possono essere presenti nel pensiero etico quotidiano.
In particolare, consente di riconoscere i modi in cui il consequenzialismo intuitivo può essere presente e influenzarsi reciprocamente nelle decisioni politiche.
Questo si aggiunge agli strumenti analitici disponibili per comprendere i valori nelle politiche antidroga e, nel processo, può aiutarci a identificare quali affermazioni normative (affermazioni di “dovere”, giudizi di valore) sarebbero logicamente necessarie per giustificare le decisioni politiche.
Anziché considerare teorie etiche come la deontologia e il consequenzialismo come fonti concorrenti di guida normativa, l’approccio mette in primo piano i giudizi di proporzionalità come incorporanti entrambe le forme di ragionamento, per chiarire come possano basarsi o influenzarsi a vicenda nel pensiero etico quotidiano.
Identificare queste forme è particolarmente utile poiché spesso le visioni etiche sono implicite e date per scontate; le persone spesso sanno cosa pensano sia giusto prima di sapere perché lo pensano (Haidt, 2012).
In primo luogo, fornisco un contesto su come il consequenzialismo e la deontologia siano stati applicati alle politiche antidroga e sostengo che le loro implicazioni normative per le politiche antidroga siano meno chiare di quanto si pensi comunemente.
Tuttavia, le teorie identificano forme di pensiero etico comunemente condivise e sono quindi utili per aiutare a identificare forme comuni di ragionamento etico che possono influenzare le politiche. In seguito, sviluppo un’analisi della proporzionalità, basandomi sul lavoro di etica applicata di Rodin (2011) e Uniacke (2011) per dimostrare che i giudizi di proporzionalità incorporano sia il ragionamento consequenzialista che quello deontologico e mostrano come possano basarsi l’uno sull’altro.
Infine, applico l’analisi a esempi di politiche di domanda, offerta e riduzione del danno, dimostrando come aiuti a identificare forme di ragionamento etico e a identificare specifiche affermazioni normative necessarie per giustificare determinate decisioni politiche.
Argomentazioni etiche dalle teorie normative
Nella letteratura sulle politiche antidroga, il consequenzialismo e la deontologia sono stati presentati come strumenti a supporto di approcci diversi (in senso lato, rispettivamente, riduzione del danno e riduzione/prevenzione dell’offerta). Tuttavia, almeno senza l’adozione di versioni specifiche di questi approcci, le loro implicazioni sono probabilmente poco chiare.
Le teorie consequenzialiste affermano che la correttezza o meno di un’azione dipende dalle sue conseguenze. La maggior parte delle forme di consequenzialismo sostiene inoltre che dovremmo massimizzare le conseguenze positive, sebbene esistano opinioni diverse su cosa sia considerato “positivo”. Per brevità, mi concentrerò sul consequenzialismo edonistico, che mira a massimizzare la felicità (o il piacere) e minimizzare la sofferenza.
Un consequenzialiste potrebbe sostenere che l’uso ricreativo di droghe tende a causare una maggiore sofferenza complessiva in una popolazione rispetto a quanto ci sarebbe senza tale uso. Sappiamo che l’uso di droghe può causare danni alla salute, decessi, sofferenza psicologica, impatti negativi sulle relazioni e sul lavoro e vari altri danni.
A fronte di ciò, potremmo valutare l’aumento di felicità derivante dall’uso di droghe, inclusi gli effetti edonistici del consumo di droghe, i piaceri derivanti dall’uso di droghe nei legami sociali e i benefici economici derivanti dai sistemi di vendita legali.
Naturalmente, un elenco completo di sofferenze e piaceri – per non parlare della quantificazione per un calcolo edonistico completo – richiederebbe una ricerca approfondita, se possibile. Ciononostante, un consequenzialista potrebbe sostenere che si può ottenere un quadro sufficientemente completo di tutte le sofferenze e i piaceri derivanti da specifiche droghe per convalidare un giudizio sul fatto che staremmo meglio, come società, se il consumo di droghe ricreative fosse ridotto.
Questo ragionamento potrebbe essere utilizzato per giustificare politiche antidroga volte a limitare o ridurre il consumo. Tale ragionamento richiederebbe anche informazioni empiriche sugli effetti delle diverse opzioni politiche, in modo da selezionare l’opzione con l’effetto ottimale sui livelli aggregati di piacere e sofferenza. Molte argomentazioni politiche sembrano assumere una forma consequenzialista, presentando prove sui danni correlati alla droga come una ragione per adottare politiche che si ritiene possano ridurre il consumo (e/o i danni).
Alcuni sostenitori della riduzione del danno presentano la loro visione come consequenzialista e sembrano considerarla un approccio neutrale rispetto ai valori, oppure allineano il consequenzialismo alla riduzione del danno (ad esempio, Wodak, 2007; Christie, Groarke & Sweet, 2008).
Sebbene sia vero che il consequenzialismo ammette almeno la possibilità che l’uso di droghe possa essere eticamente accettabile, vale la pena ricordare che si tratta di una teoria normativa, ovvero afferma affermazioni normative e quindi non è neutrale rispetto ai valori. Se è empiricamente vero che l’uso di droghe porta a più sofferenza che piacere, il consequenzialismo potrebbe implicare che l’uso di droghe sia moralmente sbagliato.
La deontologia considera la possibilità che le azioni dipendano da caratteristiche diverse dalle conseguenze. Per quanto riguarda il consequenzialismo, esistono molte forme di deontologia. Mi concentro sulla deontologia kantiana come una delle versioni filosoficamente più solide, che può essere adottata da una prospettiva laica.4 Kant sostiene che lo status etico di un’azione dipende dalla “volontà” o motivazione dell’agente (Kant, 1996, 49).
Questo spiega la visione comunemente diffusa secondo cui l’intenzione di un agente influisce sullo status etico di un’azione. Kant sostiene che le azioni sono giuste quando sono motivate dal rispetto della “legge morale”.
La deontologia è quindi spesso associata a regole o leggi. Per Kant, è importante notare che la legge morale non equivale alle leggi degli stati umani, e il rispetto della legge morale non è una questione di obbedienza a un determinato insieme di regole. Kant considera piuttosto la legge morale come principi che possono essere dedotti razionalmente dal presupposto che le regole etiche debbano essere universali, ovvero che debba essere razionalmente coerente affinché tutti adottino tale principio d’azione in ogni momento (Kant, 1996, 49-60).
Il collegamento con la volontà porta Kant a considerare le capacità umane di ragion pratica (ovvero, di ragionare sul processo decisionale pratico) come centrali per essere un agente etico, e quindi per avere valore etico. Gli esseri umani hanno un valore etico intrinseco, o dignità, legato alle nostre capacità di ragione e autonomia.
Kant presenta quindi la legge morale anche come un requisito per trattare sempre l’altra persona come un “fine in sé, non semplicemente come un mezzo da usare” (Kant, 1996, 79). Questa visione fornisce quindi una base per l’affermazione che gli esseri umani sono moralmente uguali e per la nozione di diritti umani, un concetto notoriamente difficile da comprendere per il consequenzialismo (McCloskey, 1957; Brandt, 1984).
Idee di carattere deontologico giocano un ruolo nel dibattito politico sulle droghe: alcuni sembrano ritenere che l’uso ricreativo di droghe sia intrinsecamente sbagliato, a prescindere dalle sue conseguenze.
Nei dibattiti politici, si fa talvolta appello alla questione se ci sia qualcosa di intrinsecamente sbagliato nell’uso di droghe, talvolta senza una giustificazione esplicita (per esempi, si veda Husak, 2004). Esistono possibili basi deontologiche per tale affermazione.
Una è che l’intossicazione costituisce un uso improprio del proprio corpo per il piacere, e quindi implica una motivazione che non rispetta la dignità umana in sé (Kant avanza affermazioni in questo senso in relazione all’alcol; cfr. Hoffman, 2021).
Un’altra è che l’intossicazione interferisce temporaneamente con le capacità di razionalità pratica, che fonda la dignità umana, il cui mantenimento è un dovere verso se stessi. L’intossicazione abituale potrebbe anche essere considerata sbagliata a causa del rischio di dipendenza, in quanto compromissione a lungo termine dell’agire (si veda Porter, 2020).
Se si basa su basi deontologiche, si potrebbe sostenere che, come altre forme di illecito, debba essere sanzionato legalmente. Wodak (2007) sostiene che le politiche di criminalizzazione delle droghe che hanno caratterizzato l’approccio di molti paesi per gran parte del XX secolo si basassero sul pensiero deontologico: i decisori politici giustificavano la criminalizzazione non per le sue conseguenze, ma per l’intenzione di comunicare alla popolazione che l’uso di droghe è sbagliato (si veda anche MacCoun & Reuter, 2001, pp. 57-8).
Quindi, sia il consequenzialismo che la deontologia potrebbero implicare che l’uso di droghe sia sbagliato. Tuttavia, esistono modi per contestare il ragionamento di cui sopra da entrambe le prospettive.
Weatherburn sostiene che non possiamo basarci sul consequenzialismo per valutare le politiche sulle droghe perché i costi e i benefici coinvolti sono incommensurabili e non possono essere soppesati tra loro.
Nel suo esempio:
Una politica riduce lo spaccio di droga in pubblico del 20%, ma incoraggia la condivisione di siringhe e fa sì che molti adolescenti innocenti vengano fermati, perquisiti e interrogati dalla polizia. L’altra politica riduce la condivisione di siringhe e riduce al minimo il numero di adolescenti innocenti fermati, perquisiti e interrogati dalla polizia, ma, di conseguenza, produce un livello più elevato di traffico di droga e di vagabondaggio correlato alla droga nelle aree in cui sono presenti cliniche per il metadone e nei dintorni. (Weatherburn, 2009, 337)
In altre parole, anche se disponessimo di dati affidabili su tutti i possibili danni e benefici (di per sé improbabile), non è possibile confrontarli tra loro su una scala comune. Se il calcolo edonico favorirà la limitazione, la concessione o persino l’incoraggiamento del consumo di droghe richiede valutazioni su cosa costituisca un danno o un beneficio e quanto debbano “pesare”.
Le implicazioni del consequenzialismo per le politiche sulle droghe non sono quindi chiare, in attesa di un consenso su tali questioni.
Le implicazioni della deontologia per le politiche sulle droghe non sono altrettanto chiare. Hoffman (2020) sostiene che, sebbene sia stato affermato che la deontologia implichi che l’uso ricreativo di droghe sia sbagliato, in realtà la deontologia kantiana sostiene la riduzione del danno.
Questo perché ci chiede di rispettare la dignità intrinseca delle persone, e gli approcci di riduzione del danno riconoscono e promuovono al meglio la dignità e l’autonomia delle persone che fanno uso di droghe (Hoffman, 2020; si veda anche Porter, 2020).
La deontologia kantiana fornisce un fondamento filosofico per i diritti umani, il che potrebbe giustificare l’affermazione che le persone che fanno uso di droghe hanno diritto a aiuto e supporto.
A seconda della concezione dei diritti che si intende sostenere con la deontologia kantiana, essa potrebbe persino rafforzare le argomentazioni liberali secondo cui l’uso di droghe è una scelta individuale con cui gli Stati non dovrebbero interferire.
Esistono quindi difficoltà nella valutazione etica delle politiche antidroga mediante l’applicazione di teorie etiche. Il consequenzialismo si scontra con problemi di misurazione accurata e completa e con la mancanza di chiarezza su come ponderare beni incommensurabili.
Si può sostenere che la deontologia supporti approcci politici piuttosto opposti, a seconda dell’aspetto della teoria che viene enfatizzato. Sebbene questi problemi possano essere risolti facendo appello a versioni specifiche della deontologia o del consequenzialismo, la comprensione dell’etica delle politiche antidroga come questione di applicazione di teorie etiche è limitata anche dalla mancanza di consenso su quale teoria adottare.
Propongo invece di attingere alle tradizioni dell’etica applicata, che vanno oltre l’applicazione delle teorie in questo modo top-down (Daniels, 1979; O’Neill, 2009; Archard, 2016). Questa applicazione top-down tratta le teorie normative come fonti di orientamento etico, formulando affermazioni normative sulle politiche antidroga sulla base di esse.
Insomma, si tratta di un progetto normativo. Questo articolo si propone invece di contribuire agli sforzi per approfondire la nostra comprensione di quali visioni normative e forme di ragionamento etico influenzino effettivamente il pensiero sulle politiche antidroga.
Si tratta di un progetto descrittivo, che rappresenta l’obiettivo di gran parte della letteratura recente. Spero di dimostrare come un approccio basato sull’etica applicata possa fornire risorse aggiuntive per arricchire tale etica descrittiva.
In un approccio basato sull’etica applicata, spesso partiamo dai giudizi etici pre-riflessivi e pre-teorici delle persone su casi particolari. Queste “intuizioni” possono essere utilizzate come dati per sviluppare teorie, e teorie come il consequenzialismo e la deontologia possono essere considerate sistematizzazioni astratte di intuizioni comunemente condivise. Questo modo di considerare le forme di pensiero etico rappresentate in queste teorie apre diverse possibilità per analizzare le decisioni sulle politiche antidroga.
Proporzionalità
Propongo di basarmi su un concetto fondamentale dell’etica applicata, il principio di proporzionalità.
La proporzionalità è un concetto importante in due ambiti delle politiche pubbliche maggiormente coinvolti nella risposta al consumo di droghe: la sanzione penale e la salute.
L’idea che le pene penali debbano essere proporzionate ai reati per essere giuste è un principio fondamentale dei sistemi giuridici moderni (Beccaria, 2016/1764, cap. 6) e si ritrova in sistemi giuridici antichi e testi filosofici (Bedau, 2019). Bentham lo presenta come uno dei quattro vincoli alla punizione (1999/1789, cap. 13, sezione 4).
È comunemente presente nella legislazione e nelle linee guida per l’irrogazione delle pene come principio guida per punizioni eticamente giuste (Duff, 2003).
La proporzionalità viene anche invocata per giustificare gli interventi sanitari (Resnik, 2018). Ad esempio, l’influente quadro di riferimento del Nuffield Council on Bioethics classifica gli interventi sanitari in base al loro grado di coercizione e sostiene che quanto più una politica è coercitiva, tanto maggiore è la sua giustificazione.
Una politica non coercitiva, come la fornitura di informazioni sanitarie a una popolazione, non richiede una giustificazione etica.
Una politica che orienta ma non limita la scelta individuale, come una tassa sui prodotti non salutari, è coercitiva e necessita di una qualche giustificazione. Una politica che impone la vaccinazione obbligatoria per gli operatori sanitari è altamente coercitiva e richiede una giustificazione molto forte in termini di minacce alla salute pubblica (Nuffield Council on Bioethics, 2007).
La “scala” del Nuffield si basa sulla proporzionalità, poiché implica la valutazione dei probabili benefici per la salute di un particolare intervento rispetto ai suoi costi per le libertà individuali, considerando la coercizione giustificata se proporzionata ai suoi effetti sulla salute (Have et al., 2010; Paetkau, 2024).
Sebbene la proporzionalità sia talvolta descritta nell’etica della salute pubblica come la valutazione dei benefici per la salute rispetto ai costi per le libertà individuali, qui userò il concetto in senso più ampio, come la valutazione dei benefici per la salute e di altri benefici rispetto ai costi per la salute e di altri benefici di qualsiasi politica o intervento.
I “costi” possono includere costi sanitari, sociali ed economici, nonché violazioni delle libertà individuali (presumo che questi siano considerati costi). Analogamente, i “benefici” possono includere non solo i benefici per la salute, ma anche benefici sociali ed economici e potenzialmente benefici come la promozione della giustizia sociale (anche in questo caso, supponendo che questo sia considerato un beneficio).
Tutti questi elementi possono essere considerati nel valutare la proporzionalità dell’intervento.
Applicato alla riflessione sulle politiche antidroga, l’approccio di proporzionalità ci chiede di valutare se i costi siano proporzionali ai benefici.
Non ci dice esattamente come formulare questo giudizio e richiede di sostenere che un’analisi di proporzionalità può permetterci di arricchire la nostra comprensione di come le idee etiche influenzino le politiche, poiché i giudizi di proporzionalità si basano sia sul ragionamento consequenzialista che su quello deontologico e, inoltre, possono basarsi sull’interpenetrazione di queste forme di ragionamento.
L’argomentazione inizia evidenziando due modi principali in cui la proporzionalità dell’imposizione di costi alle persone può essere giustificata: in termini di “merito” o “male minore” (McMahan, 2009, 156–7).9 Chiarisco ciascuno di questi prima di mostrare come ciascun tipo di giustificazione possa influenzare, e talvolta richiedere, l’altro.
Male minore
La giustificazione del “male minore” considera l’imposizione di un danno giustificato perché previene danni maggiori. Il danno causato nel corso dell’autodifesa potrebbe essere giustificato perché la minaccia da cui ci si difende sarebbe stata maggiore del danno difensivo, ad esempio quando qualcuno rende incapace un aggressore minacciando di morte.
I sistemi punitivi, che danneggiano i trasgressori con sospensioni della libertà o multe, sono talvolta ritenuti giustificati perché scoraggiano i reati e quindi evitano danni maggiori.
Le giustificazioni del “male minore” per arrecare danno sono consequenzialiste. Implicano il confronto di ciò che accadrebbe (probabilmente) se si interviene o meno in una situazione e la valutazione di quale scenario sia complessivamente migliore.
Laddove i costi complessivi con l’intervento siano inferiori rispetto a quanto sarebbero stati senza, la giustificazione del “male minore” indicherà che l’intervento dannoso è proporzionato.
Le giustificazioni del “male minore” spesso svolgono un ruolo nella giustificazione delle politiche sanitarie. Ad esempio, la decisione di non finanziare un trattamento costoso per una malattia rara, sebbene ciò danneggi un numero limitato di persone, potrebbe essere giustificata se destinare lo stesso finanziamento altrove evitasse danni maggiori.
Le misure che limitano il diritto alla libertà di movimento (“lockdown”) durante una pandemia potrebbero essere giustificate in quanto salverebbero molte vite. La criminalizzazione della vendita di farmaci sarebbe giustificata se ciò riducesse il danno complessivo.
Fornire uno scambio di siringhe è giustificato se i costi (ad esempio, costi finanziari, eventuali aumenti di consumo, ecc.) sono controbilanciati dai benefici (ad esempio, riduzione della diffusione di virus trasmissibili per via ematica, raggiungimento di una popolazione svantaggiata con informazioni sanitarie, ecc.).
Naturalmente, il “peso” da attribuire ai diversi danni e benefici sarà spesso poco chiaro o controverso. Diritti come la libertà di movimento sono particolarmente importanti e si può sostenere che debbano essere tutelati anche da costi elevati come la diffusione di malattie infettive.
La conclusione che la criminalizzazione della vendita di farmaci previene più danni di quanti ne causi dipenderà da cosa consideriamo come costi e benefici e da quanto peso diamo loro.
L’approccio basato sulla proporzionalità non ci dice come decidere su queste questioni, ma può darci un’idea delle rivendicazioni normative da cui dipenderanno determinati giudizi: ad esempio, l’affermazione che la riduzione della diffusione delle malattie infettive sia più importante del diritto alla libertà di movimento, o che la riduzione dei tassi di consumo di droga sia più importante degli effetti negativi della criminalizzazione.
Un tipo distinto di giustificazione del danno è che chi subisce il danno è passibile di subire tale danno o lo merita. Questo si riscontra anche in esempi di giustificazioni per l’autodifesa e la punizione.
Un aggressore che minaccia di fare del male a un altro può essere ritenuto passibile di subire un danno per difesa, poiché il suo atto immorale lo giustifica. Uno dei principali modi in cui la punizione penale viene giustificata – in contrasto con la giustificazione consequenzialista di cui sopra – è il “retributivismo”, che afferma che i trasgressori meritano danni retributivi (punitivi).
Le giustificazioni del merito sono di natura deontologica. Le giustificazioni deontologiche della punizione, ad esempio, sostengono che punire un trasgressore significa trattarlo come un agente che ha scelto la propria azione e ha agito volontariamente (Mabbott, 1939; Rawls, 1955; Pillsbury, 1988; Feldman, 1995) e quindi rispettarlo come agente morale.
I retributivisti sostengono che se la punizione è giustificata solo in termini consequenzialisti (ovvero che punire i malfattori scoraggia il male), trattiamo i malfattori come mezzi per raggiungere un fine, come “oggetti da manipolare con qualsiasi tecnica possibile” (Duff, 2003, 28) – una forma di mancanza di rispetto verso un essere dotato di valore morale (Kant, 1996, 473).
Ciò indica che il ragionamento etico implicito nel pensare al merito non si riduce al pensiero consequenzialista, che non riesce a dare senso all’idea che trattare qualcuno come mezzo per raggiungere un fine abbia una rilevanza etica.
Analogamente, le giustificazioni del merito per il danno autodifensivo implicano concetti deontologici.
Chi minaccia ingiustamente di ferire un altro non solo minaccia un danno, ma arreca anche un torto alla vittima, non riconoscendo o rispettando il suo diritto a non essere aggredito. Questo illecito di cattiva intenzione, una sorta di “danno etico” perpetrato in aggiunta al danno minacciato, è ciò che rende l’aggressore passibile di azioni difensive (Uniacke, 2011). Il danno difensivo è una risposta appropriata alla “cattiva volontà” dell’aggressore.
Si ritiene spesso che la politica sanitaria abbia un carattere principalmente consequenzialista (Nuffield Council on Bioethics, 2007), ma a volte anche forme deontologiche di giustificazione possono svolgere un ruolo.
Il ragionamento sopra menzionato, secondo cui l’uso di droghe è intrinsecamente sbagliato e quindi dovrebbe essere criminalizzato, ne è un esempio paradigmatico. Altri esempi includono il divieto, in alcuni periodi e luoghi, della ricerca su embrioni umani oltre i 14 giorni di sviluppo (Peng et al., 2022), o il riconoscimento del diritto di rifiutare cure mediche per motivi di tutela dell’integrità fisica (Walker, 2024).
Idee deontologiche sono state identificate come motore dell’opposizione a diverse politiche antidroga, come lo scambio di siringhe (Porter, 2020) e il drug checking (Ritter, 2020), apparentemente legate all’idea che le persone che fanno uso di droghe non meritino tali interventi in quanto hanno scelto volontariamente un’azione immorale.
Quale danno difensivo o retributivo sia meritato in risposta a particolari atti illeciti è ancora una volta poco chiaro e controverso. Il principio di proporzionalità non ci dice esattamente quali danni difensivi o retributivi siano giustificati, ma aiuta a chiarire a quali forme di ragionamento si può fare appello e quali affermazioni normative potrebbero giustificare determinate decisioni: ad esempio, l’affermazione che costringere qualcuno ad accettare un trattamento contro la sua volontà non è mai accettabile, o che la decisione di qualcuno di usare un farmaco dovrebbe essere rilevante in relazione alle risorse sociali che può legittimamente rivendicare.
Giustificazioni interagenti
In molti casi, i giudizi di proporzionalità possono incorporare sia intuizioni deontologiche che consequenzialiste, che interagiscono e si richiedono a vicenda.
Da un lato, i giudizi di merito sono vincolati dai giudizi consequenzialiste. Si consideri un caso di legittima difesa, in cui una persona si rende responsabile di un danno difensivo.
Tuttavia, non è responsabile di alcun tipo o grado di danno difensivo. Una minaccia di morte potrebbe giustificare un livello elevato di danno difensivo, forse incluso l’uccisione dell’aggressore. Ma una minaccia di pestare i piedi a qualcuno giustificherebbe solo un livello molto inferiore di danno difensivo (Rodin, 2011).
In altre parole, l’aggressore si rende responsabile solo di un danno difensivo proporzionato. Pertanto, per esprimere un giudizio di merito, dobbiamo impegnarci a soppesare il danno minacciato con il danno difensivo, un confronto di carattere consequenzialista.
Allo stesso modo, laddove la punizione è giustificata deontologicamente, essa è vincolata dalla proporzionalità al crimine, confrontando il danno perpetrato da qualcuno con quello impostogli retributivamente. Pertanto, i giudizi di proporzionalità sul merito incorporano un giudizio su ciò che un agente merita in risposta a un danno (minacciato o perpetrato).
I giudizi sul merito implicano un giudizio deontologico di un agente e un confronto consequenzialista interno, indispensabile, al giudizio sul merito.
D’altra parte, i giudizi di proporzionalità consequenzialisti possono essere alterati dai giudizi sul merito. Ho osservato in precedenza che, nel caso in cui un aggressore minacci di morte, il danno difensivo, incluso l’uccisione dell’aggressore, potrebbe essere giustificato, se fosse l’unico modo per prevenire la minaccia.
Questo giudizio intuitivo non può essere giustificato puramente consequenzialmente, perché non si tratta di un caso di male minore, ma piuttosto di “male” (o danno) equivalente (Uniacke, 2011).
Come sostiene Uniacke, la ragione per cui le persone tendono ad accettare la morte dell’aggressore come giustificabile è un’asimmetria in termini di merito, di valutazione deontologica degli agenti.
L’aggressore minaccia di danneggiare la vittima e le arreca anche un torto non rispettandone lo status etico e i diritti (2011, 261-2). Chi si autodifende arreca danno, ma agendo per legittima difesa non arreca alcun torto all’aggressore. L’asimmetria nel merito degli agenti implica che “valutiamo” i possibili esiti (la morte dell’aggressore o della vittima) in modo diverso. Pertanto, il peso che le cose hanno per il consequenzialista può riflettere la valutazione deontologica degli agenti.
Analogamente, le giustificazioni consequenzialiste della punizione fanno appello alla pratica di attenuare il reato attraverso la deterrenza. Un problema per tali resoconti è che potrebbero giustificare la punizione di capri espiatori innocenti, purché ciò sostenga la deterrenza (McCloskey, 1965).
Il motivo per cui sembra sbagliato punire un capro espiatorio innocente è proprio perché non lo merita: il giudizio consequenzialista è vincolato da un giudizio di merito.
In quanto tali, i giudizi di proporzionalità giustificati deontologicamente sono influenzati dal ragionamento consequenzialista e viceversa; pertanto, i giudizi di proporzionalità possono – a volte devono – incorporare entrambe le forme di ragionamento etico. Possiamo osservarlo nelle giustificazioni di alcune politiche di salute pubblica.
Ad esempio, una legge che multa chiunque fumi in auto in presenza di bambini potrebbe essere giustificata in base a una o entrambe le forme di ragionamento.
Potrebbe essere giustificata dal pensiero consequenzialista secondo cui la politica porta a ridurre il fumo in auto con bambini, scongiurando danni maggiori. Oppure potrebbe essere giustificata dal pensiero deontologico secondo cui chi sceglie di fumare in un modo che potrebbe danneggiare i bambini ha commesso un errore e merita una punizione.
Il fatto che sarebbe opportuno applicare la multa solo alla persona che fuma, e non a qualcun altro, anche nel caso in cui ciò soddisfacesse obiettivi di deterrenza, dimostra che il ragionamento consequenzialista incorpora idee deontologiche.
Il fatto che un fumatore del genere meriti una multa piuttosto che, ad esempio, la pena di morte, dimostra che il ragionamento deontologico incorpora un confronto consequenzialista.
Secondo questo approccio, le due teorie non sono in competizione per fornirci indicazioni normative su quali politiche antidroga dovrebbero essere adottate.
Piuttosto, sono modi per aiutarci a comprendere le potenziali giustificazioni delle decisioni politiche e, quindi, a comprendere forme comuni di ragionamento etico che potrebbero influenzare il pensiero politico sulle droghe.
Applicazione dell’analisi di proporzionalità alla politica antidroga
Infine, intendo applicare l’analisi della proporzionalità a diversi esempi di politiche antidroga per mostrare cosa questo approccio di etica applicata possa aggiungere ai metodi esistenti per comprendere come il ragionamento o le rivendicazioni etiche possano influenzare le politiche: può arricchire la nostra comprensione riconoscendo il ruolo di entrambe le forme di ragionamento e i modi in cui si influenzano e si vincolano a vicenda.
Queste brevi applicazioni non intendono essere analisi etiche complete di queste questioni; un progetto di questo tipo richiederebbe più spazio per considerare le caratteristiche di contesti e politiche particolari (e per riconoscere complicazioni come le affermazioni secondo cui i disturbi da uso di droghe compromettono l’agency, che tralascio ampiamente).
In primo luogo, si consideri una politica di criminalizzazione del possesso di droga, punibile con la reclusione. Una tale politica sarebbe proporzionata? Un giudizio di proporzionalità consequenzialista implicherebbe l’utilizzo di prove empiriche pertinenti sui danni del consumo di droga e della criminalizzazione del possesso; e su quanto la criminalizzazione scoraggi l’uso.
La giustificazione consequenzialista avrebbe successo se le prove empiriche indicassero che criminalizzare il possesso comporta danni minori rispetto al non farlo.
Il problema di questo approccio è che richiede di identificare cosa costituisca danno e di assegnare pesi a tipologie di danno molto diverse.
Questo può essere guidato dalle prove, così come da impegni normativi non particolarmente controversi (ad esempio, che i decessi correlati alla droga dovrebbero pesare di più dell’assenteismo sul lavoro correlato alla droga; o che il possesso con l’intento di fornire ad altri ha un peso maggiore del possesso per uso personale).
Potremmo essere in grado di accumulare prove sufficienti e un consenso sufficiente sull’importanza dei vari danni per giungere a un giudizio.
Affinché una giustificazione deontologica della politica abbia successo, dovremmo innanzitutto stabilire che l’uso di droghe è sbagliato. Come osservato in precedenza, sebbene siano possibili giustificazioni deontologiche di questa idea, non è chiaro quale sia la migliore applicazione del ragionamento kantiano al caso in questione.
Le potenziali giustificazioni deontologiche fanno riferimento ai doveri che si hanno verso se stessi, a considerare se stessi come un fine e non un mezzo, e a sviluppare le proprie capacità di ragionamento pratico. Ma questo non implica chiaramente che ogni uso ricreativo di droghe sia sbagliato; persino Kant stesso considera accettabile un’intossicazione occasionale e moderata (Hoffman, 2021).
Inoltre, anche se accettiamo che l’uso di droghe sia (deontologicamente) sbagliato, la perpetrazione di un illecito giustifica solo una punizione proporzionata.
La giustificazione deontologica della politica dovrebbe dimostrare che l’uso di droghe è un illecito sufficientemente grave da giustificare il danno punitivo. Quali illeciti siano proporzionati a quali pene è difficile da stabilire; le pene inflitte per gli stessi reati variano notevolmente nel tempo e nella giurisdizione.
I teorici retributivisti della pena non hanno fornito alcun metodo basato su principi per formulare tali giudizi (Bedau, 2019).
Tuttavia, possiamo ancora ragionare sulla proporzionalità di qualsiasi illecito connesso all’uso di droghe alla reclusione, magari confrontando l’uso di droghe con altre azioni punibili con la reclusione per verificare se siano altrettanto gravi nella giurisdizione che prende in considerazione la politica.
Un kantiano potrebbe plausibilmente pensare che limitare le libertà delle persone che fanno uso di droghe sia sproporzionato rispetto a qualsiasi uso scorretto di droghe implichi.
Finora, il ragionamento etico è simile a quello trattato nella prima sezione e potrebbe essere identificato applicando le teorie normative alle questioni in modo top-down. Tuttavia, trascura un’ulteriore implicazione dell’analisi di proporzionalità, ovvero che le giustificazioni si influenzano a vicenda.
Il ragionamento consequenzialista dipende dal peso attribuito ai diversi danni. Una valutazione deontologica di un agente che fa uso di droghe come negativo potrebbe far sì che i danni subiti dalle persone che fanno uso di droghe, comprese le violazioni dei diritti, “pesino meno” di quanto non farebbero altrimenti. In altre parole, le idee deontologiche sulla natura sbagliata dell’uso di droghe possono “far pendere la bilancia” del ragionamento consequenzialista in direzioni diverse.
Al contrario, le idee sulle conseguenze del consumo di droghe possono influenzare ciò che consideriamo meritevole per le persone che fanno uso di droghe.
L’idea culturale secondo cui l’uso di droghe possa causare danni ad altri attraverso criminalità e violenza, ad esempio, può influenzare la valutazione deontologica di un soggetto che sceglie di usare droghe nonostante tali rischi. Pertanto, il pensiero consequenzialista potrebbe influenzare un giudizio sul merito, anche in casi senza conseguenze dannose.
Riconoscere i modi in cui entrambe le forme di ragionamento possono essere coinvolte ci consente quindi di identificare aspetti del ragionamento etico non visibili da nessuna delle due prospettive prese singolarmente, il che può portare a nuove intuizioni sui modi in cui le decisioni politiche possono essere influenzate (anche da idee morali implicite o culturali sull’immoralità del consumo di droghe, o sul peso relativo di diversi danni). Una volta identificate, tali proposizioni normative possono essere ulteriormente esaminate.
Si consideri un esempio di riduzione della domanda di trattamento obbligatorio per le persone con disturbi da uso di sostanze. Una giustificazione consequenzialista della proporzionalità di tale politica dipenderebbe dal fatto che il trattamento obbligatorio per le persone con disturbi da uso di sostanze porti a una riduzione dei danni complessivi, basandosi su dati empirici rilevanti sui suoi costi ed effetti.
I costi potrebbero includere non solo i costi finanziari, ma anche la violazione del consueto diritto delle persone a rifiutare i trattamenti medici (Walker, 2024) e, a seconda della modalità di trattamento, dei loro diritti alla libertà.
La giustificazione consequenzialista dipenderebbe anche da affermazioni normative che assegnano pesi specifici ai danni evitati, ai diritti violati e ai costi finanziari, e da indicazioni per confrontare questi danni piuttosto diversi.
In alternativa, la proporzionalità della politica potrebbe essere giustificata deontologicamente, tenendo conto di ciò che le persone con disturbi da uso di sostanze meritano.
Ancora una volta, ciò implica inizialmente se avere un disturbo da uso di sostanze significhi che l’agente abbia commesso un errore, giustificando l’essere sottoposto a un trattamento che potrebbe preferire rifiutare e la perdita della sua libertà di rifiutarlo.
La maggior parte delle giurisdizioni è stata reticente a violare il diritto di rifiutare le cure mediche, che si ritiene derivi dal diritto all’integrità fisica, in altri tipi di trattamento.
Ci sono casi in cui la vaccinazione è stata imposta, con la motivazione che la mancata vaccinazione potrebbe arrecare danni ad altri (Curtis, 2015). In alcune giurisdizioni è stato adottato un trattamento obbligatorio (o coercitivo) per i disturbi da uso di sostanze, talvolta legato ai sistemi di giustizia penale, o disponibile nei casi in cui un individuo rappresenti un grave rischio per sé o per gli altri (Coleman, Ridley & Christmass, 2021).
Affinché una giustificazione deontologica di tale politica abbia successo, dovremmo pensare che la revoca del diritto di rifiutare le cure sia proporzionata a qualsiasi torto commesso dalle persone con disturbi da uso di sostanze.
Finora, ancora una volta, si potrebbero riconoscere questi punti applicando ciascuna teoria; ma ulteriori approfondimenti su come il pensiero politico possa essere influenzato dai valori possono essere ottenuti riconoscendo che entrambe le forme di ragionamento possono essere coinvolte e possono influenzarsi a vicenda.
Il ragionamento consequenzialista potrebbe essere influenzato dalla convinzione che i disturbi da uso di sostanze derivino da una serie di scelte moralmente sbagliate (Kennett, Vincent e Snoek, 2014), rendendo la perdita della libertà di rifiutare il trattamento meno rilevante nel calcolo.
In alternativa, se un deontologo dovesse sostenere che determinate scelte di consumo di droghe siano moralmente ammissibili, al punto che le persone con disturbi da uso di sostanze non possano essere incolpate per averli, potrebbe concludere che ulteriori restrizioni della loro libertà non siano meritate.
Il consequenzialista deve trovare un modo per assegnare pesi a costi e benefici specifici, e un modo per farlo è attraverso la valutazione deontologica degli agenti rilevanti. Al contrario, il ragionamento deontologico potrebbe essere influenzato da un confronto consequenzialista, secondo cui l’errore commesso assumendo droghe rischia di avere conseguenze sufficientemente dannose per gli altri da poter sospendere il consueto diritto all’integrità fisica.
Ancora una volta, l’approccio basato sulla proporzionalità non risolve la questione se il trattamento obbligatorio sia proporzionato, poiché il giudizio finale dipenderà da affermazioni normative sull’importanza dei diversi costi e benefici e dalla nostra valutazione etica degli agenti interessati dalla politica.
Ma va oltre l’applicazione top-down delle teorie, consentendoci di vedere che entrambe le forme di ragionamento non solo possono essere invocate insieme, ma si influenzano a vicenda, quindi la misura in cui costi e benefici vengono considerati può comportare una valutazione deontologica dell’uso di droghe, mentre le ipotesi sulle conseguenze del consumo di droghe possono influenzare le valutazioni di merito.
Questo può aiutarci a identificare specifiche affermazioni normative che sarebbero necessarie per giustificare particolari decisioni politiche sul trattamento obbligatorio, ad esempio, l’affermazione che i diritti all’integrità fisica sono meno (o più) importanti se qualcuno è responsabile del suo disturbo medico, o l’affermazione che i diritti all’integrità fisica sono meno importanti dei potenziali danni imposti dalle persone che continuano a fare uso di droghe. Queste affermazioni possono poi essere ulteriormente analizzate.
Infine, si consideri una politica di riduzione del danno, come le sale di iniezione sottoposte a supervisione medica (MSIR). Una giustificazione consequenzialista prenderebbe in considerazione i dati empirici sui benefici, come la riduzione dei decessi per overdose, la possibile riduzione dei rifiuti da siringhe, il raggiungimento di una popolazione sanitaria carente di servizi (Drucker et al., 2016) e (potenzialmente) la segnalazione dell’attenzione e del rispetto della comunità nei confronti delle persone che fanno uso di droghe (Dea, 2020; Hoffman, 2020); rispetto a oneri come l’investimento finanziario, i costi per i servizi pubblici, come il possibile aumento dei rifiuti da siringhe, l’esposizione delle persone a testimoni di consumo o spaccio di droghe e le conseguenti ricadute sulle attività commerciali locali (Whiteside & Dunn, 2022; Lay, 2023; osservando che questi effetti sono controversi); e l’invio di un messaggio che il consumo di droghe è accettabile. È particolarmente difficile stabilire quanto debbano “pesare” costi come i servizi pubblici e la comunicazione (da entrambe le parti).
Una complicazione nell’applicazione di un approccio di proporzionalità agli MSIR è che alcuni dei danni, da entrambe le parti, sono presumibilmente generati non dall’esistenza di un MSIR in sé, ma dall’esistenza di un MSIR in un contesto di proibizione generale delle droghe.
Questo contesto tende a rendere le droghe disponibili più pericolose, le siringhe più difficili da reperire, lo spaccio più diffuso per strada e così via. Ciò indica che altre modifiche politiche potrebbero annullare questi costi e potremmo quindi applicare un’analisi di proporzionalità a tali modifiche.
In alternativa, un giudizio di proporzionalità deontologica potrebbe valutare se le persone che fanno uso di droghe meritino un servizio come un MSIR. Questo giudizio dipenderà ancora una volta dal fatto che il consumo di droghe sia considerato o meno un’azione sbagliata e, in tal caso, dalla sua gravità.
Porter sostiene che le intuizioni laiche su ciò che le persone che fanno uso di droghe meritano siano alla base delle controversie sulle misure di riduzione del danno; che vi sia un ragionamento di fondo secondo cui “poiché i consumatori di droga creano e mantengono le circostanze che li mettono in pericolo attraverso le loro cattive azioni, non abbiamo alcun obbligo di aiutarli” (2020, 366).
Sostiene inoltre che questo ragionamento non è valido, perché anche ammettendo che il consumo di droghe sia un illecito, non è un illecito così grave da giustificare conseguenze come la cattiva salute e il cattivo benessere, ovvero è sproporzionato.
Potremmo andare oltre e sostenere che il ragionamento deontologico supporterebbe la previsione di un MSIR, sia rifiutando l’idea che il consumo di droghe sia (deontologicamente) sbagliato; sia sostenendo che il consumo di droghe è un illecito minore rispetto al illecito di lasciare morire qualcuno quando abbiamo i mezzi per impedirlo (a volte nota come “regola del salvataggio” (Cookson, McCabe e Tsuchiya 2008)).
Ancora una volta, possiamo integrare le analisi precedenti con un quadro che riconosca che entrambe le forme di ragionamento etico potrebbero essere valide e influenzarsi a vicenda. Le idee su ciò che le persone che fanno uso di droghe meritano influenzeranno l’importanza che attribuiamo ai costi e ai benefici. Se il consumo di droghe è un grave errore, forse è meno importante ridurre le overdose; se non è così grave o non è affatto sbagliato, ridurre le overdose potrebbe superare qualsiasi costo per il bene pubblico.
Al contrario, i giudizi sul fatto che le persone che fanno uso di droghe meritino aiuto implicheranno la valutazione dei costi per fornirlo rispetto alla forza di questo deserto.
Riconoscere questo può esercitare pressione su, ad esempio, una decisione politica di non fornire un MSIR, chiarendo che la decisione si basava su affermazioni normative secondo cui la vita delle persone che fanno uso di droghe è meno importante del bene pubblico, o che il consumo di droghe è sufficientemente moralmente sbagliato da rendere illegittime le pretese sulle risorse sociali e sanitarie, e stimolando una discussione sull’accettabilità di tali impegni normativi.
Conclusione
Spero di aver dimostrato che l’approccio di proporzionalità è utile per la considerazione delle questioni etiche relative alle politiche antidroga. Come abbiamo visto, l’approccio di proporzionalità non implica di per sé conclusioni su ciò che è etico fare, ma potrebbe farlo se combinato con specifici impegni normativi (che potrebbero derivare da specifiche versioni del consequenzialismo o della deontologia).
Stimolando un dibattito esplicito e ragionato su queste questioni, potrebbe anche aiutarci a confrontarci con i presupposti morali che derivano dalla lunga storia di moralizzazione del consumo di droghe, che potrebbero influenzare il pensiero politico e i giudizi intuitivi delle persone sulle proposte politiche. Tuttavia, l’obiettivo principale qui è quello di contribuire ai nostri strumenti concettuali per comprendere come il ragionamento etico e specifici impegni normativi possano influenzare il pensiero sulle politiche antidroga.
L’approccio di proporzionalità è in grado di andare oltre la semplice applicazione delle teorie consequenzialiste o deontologiche, consentendoci di considerare entrambe le forme di ragionamento e i modi in cui possono basarsi l’una sull’altra, aggiungendo sfumature alle analisi di quali idee possono influenzare le decisioni politiche e all’identificazione di specifici valori alla base delle decisioni.
Mary Jean Walker: Scrittura – revisione e editing, Scrittura – bozza originale, Software, Amministrazione del progetto, Metodologia, Indagine, Analisi formale, Concettualizzazione.